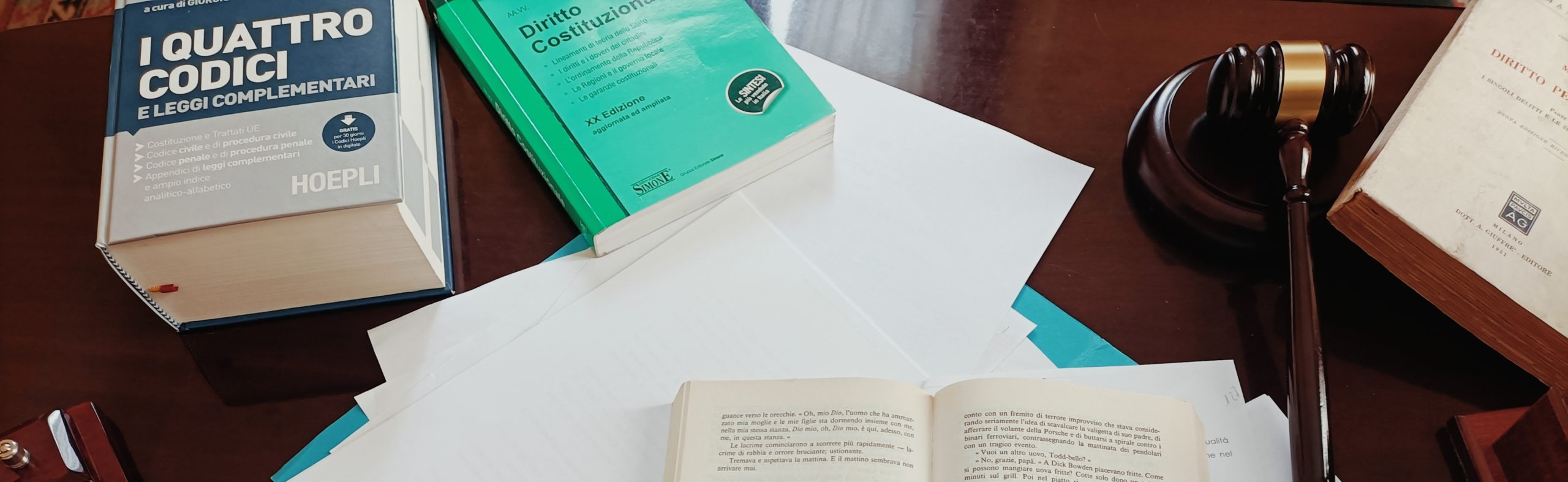Diritto processuale penale
La Testimonianza
Era un freddo mattino di fine Febbraio, quando indossai per la prima volta la toga, in occasione del mio debutto in udienza.
Mia mamma voleva venirmi a vedere in aula ma io glielo avevo impedito con forza, a costo di ferire i suoi sentimenti. Se proprio dovevo affondare, meglio che lo facessi da solo.
Attraverso i finestroni del palazzo di giustizia penetravano i bagliori di un sole invernale.
L’aula di udienza era al terzo piano e mio zio mi condusse fino alla soglia. Aveva percorso la scalinata di marmo dispensando cenni di saluto a magistrati e colleghi, con l’aurea troneggiante del principe del foro. Io, invece, mi sentivo come un pesce fuor d’acqua, benché desiderassi fare bella figura, agli occhi dello zio forse più che di me stesso.
La nostra udienza era fissata alle undici e si stava tenendo quella in calendario per le dieci. In verità, ancora oggi, fatico a comprendere per quale misteriosa ragione sia di fatto impossibile tenere le udienze con puntualità ed i magistrati, a dispetto del loro ruolo di potere e responsabilità, si ostinino spesso ad occupare il loro trono d’udienza mezz’ora dopo il previsto.
Ci accomodammo su una fredda panchina di marmo a ripassare gli articoli del codice di procedura penale che trattano dell’assunzione della prova testimoniale (1).
Lo zio mi interrogò con la brutalità dell’implacabile esaminatore ed io risposi con voce che sembrava morire in gola, terrorizzato all’idea di sbagliare. Ricordavo che le generalità dei testimoni, con tanto d’indirizzo di abitazione, andavano indicate in un documento scritto, chiamato lista testi (2), da depositare in cancelleria entro l’ottavo giorno precedente la prima udienza dibattimentale, che al teste non potevano essere richieste valutazioni od opinioni personali ma che le domande dovevano riguardare solo i fatti di causa. Tuttavia alla domanda di dove fosse la cartolina di ritorno della raccomandata di convocazione del testimone, mi scomposi non poco e cominciai a frugare nella mia borsa e nelle tasche interne della giacca, rischiando persino di lacerarle. Poi lo zio la estrasse con aria di superiorità dalla solita cartelletta plastificata multiuso, che teneva sotto il braccio, e mi fece un sorrisetto sardonico. «Mai presentarsi in udienza senza la prova di avere fatto il proprio dovere! La vita dell’avvocato è la più dura del mondo, Ale. Siamo una specie in via d’estinzione, caro mio. Il pubblico ministero si dimentica di citare un testimone? “Prego, si accomodi al prossimo giro” ed il giudice rinvia l’udienza senza battere ciglio. Se ne dimentica l’avvocato? Condannato alla pena capitale, con la pistola del cliente puntata alla tempia! Dichiarato decaduto dalla prova! E ZAC, sei morto come uomo e come professionista….».
Trovai quelle parole davvero poco incoraggianti e quando si aprì la porta di legno dell’aula numero tre ed una donna si affacciò per pronunciare il cognome del nostro cliente, ch’era imputato di lesioni personali gravissime, sentii il cuore salirmi in gola.
Entrai nell’aula a capo chino, come un condannato che procede verso il patibolo, mentre nella testa mi risuonavano come un disco rotto gli ammonimenti pronunciati da zio Arturo con la solita enfasi, la sera prima: “Primo: non fare al testimone domande di cui non sei in grado di prevedere la risposta e ricorda che il dubbio è il nostro alleato più prezioso e che l’onere della prova spetta all’accusa. Secondo: non irritare mai il testimone, è il tuo alleato ma potrebbe anche diventare il tuo peggior nemico…Terzo: abbi pazienza con il tuo testimone…la fretta è nemica di una buona strategia difensiva”.
Sarei stato in grado di soddisfare le aspettative di colui che mi aveva accolto nel suo studio, fingendo di stimarmi?
Lo zio, con mio vivo disappunto, non mi aspettò fuori dall’aula come avevo immaginato ma ci entrò, sedendosi oltre il tramezzo di legno che separava il vero e proprio foro d’udienza dalla zona riservata al pubblico. Mi guardai alle spalle e vidi due occhi da corvo che mi testavano, pronti a cogliere ogni mia debolezza.
Il giudice rovistò tra le carte del fascicolo, perché non riusciva a visualizzare il certificato penale dell’imputato e l’attestazione dei carichi pendenti.
Così l’attesa che l’udienza cominciasse si protrasse, in un silenzio denso di aspettative, per cinque interminabili minuti.
Filamente il magistrato pose su di me i suoi occhi grigi. «Avvocato Mayer, dobbiamo sentire il suo testimone, il signor Gerundo. E’ presente?».
«Credo di sì, signor giudice. L’ho regolarmente citato». E sventolai la cartolina di ritorno della raccomandata.
«Allora lo faccia entrare».
Mi affacciaia sul corridoio e pronunciai con voce stentorea il nome del mio uomo, quello che avrebbe dovuto sconfessare l’accusa.
Dalla panchina di marmò si sollevò un anziano omaccione corpulento, che indossava un maglione rosso sgargiante. Fece qualche timido passo in direzione dell’aula, col foglio dell’intimazione a comparire stretto nella mano destra. Mi accorsi che deambulava con l’aiuto di un bastone, cui si aggrappava quasi fosse un’ancora di salvezza.
Il giudice fece un sorriso assertivo. «Buongiorno Signor Gerundo».
«Buongiorno, sua eccellenza».
Il magistrato accentuò il suo sorriso. «Signor giudice può bastare».
«Buongiorno, signor Giudice».
Il testimone fu invitato, con un cenno della mano, ad accomodarsi su una sedia posta a lato del banco del giudice. Recitò la solita inutile filastrocca, che il mio professore di procedura penale pretendeva che noi studenti imparassimo a memoria: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Roba d’altri tempi, pensavo, chi può ancora credere che la verità sia davvero sentita come un obbligo morale? Meno male che la parola LO GIURO era stata depennata dalla Corte Costituzionale poiché implicante un inaccettabile obbligo di credere in Dio e di professare una religione.
Quell’uomo declinò le proprie generalità e dichiarò di non avere interesse in causa, né rapporti di parentela o di lavoro con le parti in causa.
Consultai con frenesia i miei appunti, benché mi fossi già impresso nella memoria ogni dettaglio. Quell’uomo avrebbe dovuto dichiarare che a picchiare a sangue un povero venditore ambulante era stato un giovinastro di passaggio e non il nostro cliente che di anni ne aveva cinquanta suonati.
Quando il giudice mi diede la parola «Prego, avvocato Mayer» scattai in piedi, schiarendomi la voce, mentre un lieve formicolio mi prese la mano destra. «Buonasera Signor…».
Sentii un risolino alle mie spalle. «See, perché non buonanotte….». Mi voltai e vidi un’intera scolaresca, con tanto di professoressa, in gita al palazzo di giustizia e mi chiesi quando diavolo fossero entrati e da dove fossero passati.
«Buongiorno». Mi corressi, quasi balbettando. «La sera del 24 maggio 2012 lei si trovava in via Vittor Pisani, vero?».
Il testimone confermò, seppur con voce tremante, ed io proseguii fiducioso, come un soldato in missione. «Si ricorda di avere assistito ad un rissa?».
Il giudice, un omaccione calvo dallo sguardo bonario, mi lanciò un mezzo sorriso, di quelli che si riservano con vanitoso buonismo ai debuttanti. «Avvocato Mayer, rissa è un concetto prettamente giuridico che implica la partecipazione di più persone ad una zuffa. Possiamo evitare espressioni tecniche e fare al teste domande più chiare?».
Sentii una fitta allo stomaco, come fossi stato punto sul vivo. Se avessi avuto più autostima avrei reagito all’istante, invece sprofondai in un imbarazzato silenzio di trenta interminabili secondi, rotto dal ricordo ingombrante di uno degli insegnamenti retorici di zio Arturo: “un avvocato che sta zitto è come una guardia giurata che si fa disarmare! Tu parla sempre! Se non sei padrone della situazione, allora fingi che tutto sia sotto controllo!”.
E così feci, intuendo che lo sguardo del mio mentore mi stava trapanando la nuca con implacabile severità. Feci un bel respiro e ripresi di slancio. «Può dire qualcosa sulla fisionomia dell’aggressore, cioè di quello che ha sferrato il pugno? Tipo età, stazza, corporatura…».
Il vecchio scosse la testa. «Non ricordo bene. Dovrei…».
Quel “non saprei” mandò fuori giri il mio cervello già in ansia da prestazione. Qualcosa dunque stava andando storto? Come si permetteva un testimone regolarmente citato di mostrare incertezze? Sentii una vampata calda salirmi alla testa, una specie di artiglio da predatore, e mi rifiutai di continuare ad ascoltare. Le mie paure si trasformarono in un impulso feroce. «Come? Non ricorda?».
«E’ passato tanto tempo, avvocato…abbia pazienza e….».
«E’ passato tanto tempo? Ma questo fatto non l’ha colpita? Non le è rimasto impresso nella mente? Non è qualcosa che dovrebbe impressionare un malcapitato passante? Parliamo di un’aggressione, per Dio!». Era come se urlassi a me stesso “Basta essere un gattino da salotto! Questa è l’occasione giusta per combattere, per la miseria”.
«Davvero, avvocato, sono un po’ confuso, mi dia il tempo…». Non gli lasciai finire la frase e mi avventai sulla preda, per azzannarla. «Lei è sotto il vincolo del giuramento, se lo ricordi!». Mi volsi di scatto verso il magistrato, che mi fissava sbigottito. « Signor Giudice, la prego di ricordare al teste che ha l’obbligo di dire la verità!». A distanza di tempo non saprei dire che cosa mi successe quel mattino. Sentivo il dovere di essere duro, implacabile, VINCENTE, cioè tutto il contrario di ciò che pensavo di essere, specie agli occhi della mia aguzzina, la bella ed esigente Claudia.
Fu il giudice a destarmi da quel delirio, col suo timbro autorevole. «Avvocato, non mi metta in bocca i suoi pensieri. Ha detto che non ricorda, punto. Lei ha la facoltà di entrare nella mente del teste e sostenere che la frase “non ricordo” sia una falsità? Se poi lei avesse pazienza e lo lasciasse finire…».
Troppo tardi: l’ansia mi attanagliava ogni muscolo e reagii all’insicurezza nel modo più stupido, caricando a testa bassa, come un bisonte. «Mi scusi, ma lei soffre di alzahimer forse?».
Il vecchio reclinò il capo di lato, con due occhi mortificati. «Purtroppo si!».
Un giovanile riso corale si sollevò alle mie spalle, tanto che il giudice dovette battere un pugno sul suo tavolo ed ordinare il silenzio.
Quelle parole fatali “PURTROPPO SI” sibilarono nell’aria immobile, come un crudele colpo di scure.
Le braccia mi caddero lungo i fianchi ed io avrei desiderato sparire all’istante, inghiottito dal pavimento, per non riemergere più.
Il giudice si aggiustò i pendagli della toga, che gli ciondolavano lungo le spalle, e mi inquadrò con due occhi freddi e grigi. «Avvocato, dove vuole andare a parare? Guardi che il testimone l’ha indicato e citato lei. Questo è il suo testimone, non lo dimentichi. A dire il vero trovo offensivo il suo modo di procedere e ne terrò conto nella mia decisione».
Vidi danzare davanti a me, come proiettate su uno schermo gigante, poche sinistre parole “Primo: non fare al testimone domande di cui non sei in grado di prevedere la risposta…ABBI PAZIENZA CON IL TUO TESTIMONE” e mi sentii impotente, sconfitto, inadeguato. Come se Claudia avesse ragione a considerarmi un buono a nulla.
Il giudice si piegò in avanti, quasi volesse scrutarmi in profondità. «Avvocato Mayer, possiamo congedare questo signore? Ha detto semplicemente che non ricorda, almeno finchè lei l’ha lasciato parlare. Non ricordare non mi pare costituire reato, soprattutto alla luce delle tristi circostanze che il teste ha riferito».
Due monosillabi mi sfuggirono dalle labbra, in un soffio. «Va bene». Poi raccolsi la poca dignità che mi restava e mi voltai all’indietro.
Zio Arturo era accigliato, scuoteva la testa e stringeva tra le mani il tramezzo di legno. Per un istante sospettai che quelle manone dalla inesorabile presa potessero stringersi attorno al mio collo.
Prova testimoniale
La testimonianza va annoverata tra i principali mezzi di prova esperibili nel processo penale, di certo la più frequente nella prassi forense. E’ ricompresa tra i mezzi di prova definiti “orali” poiché si incentra su dichiarazioni rese verbalmente in udienza circa fatti del processo da persone che ne sono a conoscenza.
La sua ammissione, e correlativa assunzione nel giudizio penale, è disciplinata dagli artt. 194 e ss.ti c.p.p.. La testimonianza viene assunta in dibattimento, o, come vedremo, in sede di incidente probatorio, alla presenza di un giudice terzo e nel contraddittorio delle parti. Per questo si distingue dalle sommarie informazioni testimoniali (c.d. Sit) acquisite nella fase predibattimentale delle indagini preliminari dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega dello stesso. Le sit, non essendo acquisite in dibattimento innanzi ad un giudice terzo e nel contraddittorio delle parti, non costituiscono piena prova dei fatti per cui è processo ma, viceversa, assurgono al rango di meri elementi di prova suscettibili di orientare il PM tra le opzioni alternative della richiesta di archiviazione della notizia di reato per infondatezza dell’ipotesi accusatoria o dell’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, ove il rito preveda la celebrazione dell’udienza preliminare, ovvero, in caso contrario, notifica all’imputato della citazione diretta a giudizio).
La testimonianza si configura quale dichiarazione di un terzo, estraneo alla vicenda giudiziaria, relativa a fatti rilevanti per la definizione nel merito della stessa. Proprio l’estraneità del teste agli interessi in gioco nel processo nel quadro del quale è chiamato a deporre è alla base della valutazione del giudice circa l’ammissibilità del mezzo istruttorio. L’estraneità del teste all’oggetto del processo, tuttavia, non deve condurre ad un’apodittica ed aprioristica affermazione di credibilità del medesimo da parte del giudice. Quest’ultimo, infatti, dovrà sempre effettuare un preciso e puntuale accertamento circa la sussistenza della credibilità in capo al dichiarante così come impone la regola generale dell’art 192 c.p.p. in punto di valutazione delle prove. Tale vaglio di credibilità da parte del giudicante dovrà essere particolarmente attento ed approfondito nel caso in cui il teste sia la persona offesa dal reato, vieppiù nel caso in cui la stessa si sia frattanto costituita parte civile per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa del fatto-reato per il quale si procede. In tal caso, in effetti, le dichiarazioni testimoniali sono rese da persona portatrice di interesse, anche economico, diametralmente opposto a quello dell’imputato.
Caratteristiche intrinseche della prova testimoniale e obblighi del teste
Per quanto attiene all’oggetto della testimonianza, il legislatore si premura di precisare come la stessa debba riguardare esclusivamente fatti determinati e specifici e non puri giudizi sulla moralità dell’imputato, apprezzamenti personali o voci correnti nel pubblico.
Sarà preciso onere del difensore dell’imputato, allorché il pubblico ministero ovvero il difensore di parte civile articolassero domande che demandino al teste opinioni personali, apprezzamenti soggettivi o giudizi etici, formulare opposizione affinché il giudice possa non ammettere la domanda stessa.
Il legislatore riconosce la astratta capacità processuale di testimoniare ad ogni persona, indipendentemente, dunque, dal raggiungimento o meno della maggiore età.
Tale nozione deve esser tenuta distinta dalla concreta capacità fisica e mentale di deporre in giudizio che vale ad attribuire credibilità ed attendibilità al teste. Tale ultima capacità può divenire oggetto di accertamenti che, di solito, si rendono necessari soprattutto nel caso di teste minorenne ovvero ove sussistano dubbi circa la sussistenza, in capo al dichiarante, di effettive ed attuali facoltà di discernimento. In tal caso, infatti, è necessario un puntuale accertamento circa l’esistenza della predetta capacità ad opera del giudice, se del caso anche mediante il ricorso a perizia scientifica di natura psichiatrica.
Nel caso in cui il testimone sia legato all’imputato da un rapporto di parentela, il legislatore si premura di prevedere, in capo a questi, la facoltà di astenersi dal testimoniare. Ciò sia per il fatto che un tormento di coscienza potrebbe riflettersi sull’obiettività delle risposte rese dal teste alle domande formulategli, sia per riconoscere al teste medesimo facoltà di stabilire la propria idoneità a ricoprire un ruolo processuale tanto rilevante in un frangente di evidente coinvolgimento emotivo. Di tale facoltà il teste deve esser edotto dal giudice prima dell’inizio della deposizione. Il giudice avrà cura di precisare, tuttavia, che, nel caso in cui il soggetto rinunciasse alla facoltà di astensione, graverebbe comunque in capo allo stesso l’obbligo di rispondere alle domande rivolte dal pubblico ministero e dai difensori delle parti private e di rispondere secondo verità.
Tra i principali vincoli in capo al teste vi è, infatti, l’obbligo, una volta citato nel processo, di presentarsi all’udienza prestabilita per la sua audizione, di rispondere alle domande formulate dalle parti e di rispondere secondo verità (un identico obbligo non incombe in capo all’imputato che è esentato dal dovere di verità, a garanzia assoluta del libero esercizio del diritto fondamentale di difesa in giudizio. Tuttavia l’imputato ha l’obbligo di dire la verità sulle proprie generalità, sulle proprie condizioni di vita e sugli eventuali processi pendenti e precedenti sentenze di condanna a proprio carico). Qualora il teste, senza addurre o documentare un legittimo impedimento, omettesse di presentarsi in aula, il giudice potrà disporne l’accompagnamento coattivo ed anche irrogare una sanzione pecuniaria. Il testimone, generalmente inteso e salvo casi particolari, ha dunque un preciso dovere di riferire all’autorità giudiziaria quanto a sua conoscenza, in maniera puntuale e precisa, ed ha l’obbligo di riferire il vero, pena, diversamente, il rischio di incorrere in fattispecie delittuose di particolare gravità, in primis quella della falsa testimonianza.
Il testimone, tuttavia, gode del privilegio dell’esonero dall’autoincriminazione. Ciò significa che, per il principio riassunto nel brocardo latino “nemo tenetur se detegere” (nessuno può essere obbligato a danneggiare se stesso), costui non è tenuto a rendere dichiarazioni che implichino l’ammissione di una propria responsabilità in relazione al fatto per cui si procede o ad altri fatti che potrebbero formare oggetto di separate imputazioni. Stante il suo ruolo terzo rispetto alla vicenda giudiziaria, per l’audizione dello stesso non è richiesta la necessaria presenza del difensore.
I doveri del testimone, in punto di verità delle dichiarazioni, emergono anche dalla formula sacramentale che questi, prima di rendere la propria testimonianza, deve recitare in aula, su invito del giudice : “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”.
Dopo il deposito della lista testi in cancelleria, il pubblico ministero ed i difensori delle parti private, alla prima udienza dibattimentale e concluse le formalità di apertura del dibattimento, hanno la parola per le richieste istruttorie. L’avvocato diligente insisterà per l’ammissione delle prove dedotte nel corpo della lista testi. A seguito della riforma Cartabia e sulla scorta della nuova formulazione dell’art. 493 comma I cpp, le parti private sono tenute ad illustare al Giudice i profili di ammissibilità delle richieste di prova per testi.
Tipologie di prova testimoniale
A margine della testimonianza genericamente intesa, vale a dire di quella preveduta e disciplinata dagli artt. 194 e seguenti c.p.p, il legislatore si premura di dettare una puntuale disciplina di altre forme di testimonianza che, rispetto allo schema generale, presentano taluni elementi di differenziazione nonché caratteristiche peculiari meritevoli di specifica disciplina.
La testimonianza indiretta o de relato
Tra le varie ipotesi speciali, analiticamente disciplinate nel codice di rito, l’art. 195 c.p.p. regola la testimonianza indiretta o de relato.
L’elemento caratterizzante tale forma di prova testimoniale è da ravvisarsi nel fatto che il testimone si trova a dover riferire in merito a fatti dei quali non ha avuto diretta conoscenza o percezione ma che ha appreso da terzi. Da qui, la previsione di alcune cautele normative in punto di assunzione di una prova soggetta ad evidenti pericoli di contaminazione/manipolazione.
L’art 195 c.p.p. prevede infatti la necessità, ai fini dell’utilizzabilità delle risultanze dichiarative del teste de relato, che venga sentito anche colui che ha fornito le informazioni, ossia il c.d. testimone di riferimento. Ciò a garanzia di una piena attendibilità delle dichiarazioni medesime che debbono corrispondere a percezioni auditive o oculari dirette e non mediate da rielaborazioni di terze persone, per loro natura sempre foriere di contaminazioni seppur involontarie.
Il comma 7 della detta norma statuisce l’impossibilità di utilizzare la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame. Tale regola generale incontra, tuttavia, tre eccezioni tassativamente previste al comma 3 del medesimo art. 195 c.p.p.:
- il caso di morte, irreperibilità o infermità (ovvero impossibilità di formulare dichiarazini per grave malattia) del teste di riferimento. Pare ovvio sottolineare che, nel caso in cui il dichiarante faccia riferimento, quale propria fonte di conoscenza dei fatti oggetto della deposizione testimoniale, a persona deceduta, spetterà al giudice valutare con estrema prudenza l’attendibilità del dichiarante stesso (la prassi di chiamare in causa i defunti è più in voga di quanto si possa sospettare).
La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che la sanzione dell’inutilizzabilità della deposizione opera solo se vi è stata richiesta di parte di escussione del teste di riferimento ed il giudice non ha ammesso la prova (pertanto sarà cura di un diligente avvocato, in presenza di una testimonianza de relato sollecitare, anche incalzandolo, il dichiarante affinché riveli la sua fonte e, in caso ciò avvenga, formulare istanza per l’audizione del teste di riferimento). Se, invece, le parti non avanzano tale richiesta, la dichiarazione de relato è pienamente utilizzabile (salve le valutazioni del giudicante, sempre discrezionali seppur bisognose di congrua motivazione, in punto di credibilità ed attendibilità del teste). Del pari, la dichiarazione è utilizzabile se le parti rinunciano espressamente all’assunzione del teste di riferimento.
Il comma 2 della norma prevede, in ogni caso, che il Giudice possa d’ufficio disporre l’audizione del teste di riferimento.
I commi 4 e 6 della norma in esame impongono, tuttavia, delle limitazioni circa i soggetti che possono rendere testimonianza de relato. In particolare, si prevede il divieto di testimonianza indiretta da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in relazione al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a e b c.p.p. (trattasi delle sommarie informazioni testimoniali acquisite da persone che possono riferire circostanze utili alle indagini nonché delle sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni rese da colui nei cui confronti vengono svolte le indagini) ben potendo invece testimoniare in tutti gli altri casi.
Ancora, non è possibile testimoniare su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p. (sul segreto professionale) in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano già deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. Trattasi di ministri di culto, avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, altri professionisti assistiti dal segreto professionale, medici, infermieri, ostetriche ed altri esercenti la professione sanitaria, pubblici ufficiali, pubblici impiegati ovvero esercenti un pubblico servizio. Ovviamente il diritto/dovere del silenzio s’impone solo circa le notizie apprese in ragione del proprio ufficio, servizio, incarico etc. Qualora si prevedesse, in capo all’avvocato, la facoltà di dichiarare in giudizio quanto appreso dal proprio assistito si minerebbe il vincolo di fiducia sotteso al mandato difensivo e si porrebbero indebite limitazioni al pieno esercizio del diritto alla difesa processuale.
Il testimone assistito
Altra peculiare figura di prova testimoniale è il teste assistito di cui all’art 197 bis c.p.p. La disciplina di questo istituto è alquanto barocca, un vero ginepraio difficile da districare. Qui di seguito proveremo a fare luce negli oscuri meandri delle norme in questione.
Con riferimento al teste assitito, l’elemento caratterizzante è da ravvisarsi nel fatto che colui che riveste il ruolo di testimone non è terzo ed imparziale rispetto alle vicende oggetto di accertamento giudiziale, bensì riveste la qualità di imputato in un processo collegato o connesso a quello in cui viene chiamato a deporre innanzi alla autorità giudiziaria.
Proprio la peculiare e complessa posizione di tale testimone, gravato comunque dell’obbligo di dire la verità, ha imposto la necessità, riconosciuta anche dal legislatore, di prevedere alcune accortezze per quanto attiene alle modalità di acquisizione della prova orale in simili casi.
In primo luogo, preme sottolineare come il ruolo di testimone assistito non possa esser rivestito da qualsivoglia coimputato. Il legislatore, infatti, si premura di precisare, ai commi 1 e 2 dell’art. 197 bis cpp che la veste di teste assistito può essere assunta solo:
- dall’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 c.p.p. o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b) c.p.p. quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena;
- dall’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) c.p.p., o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b) c.p.p., nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c) c.p.p: “se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197 bis”
In quest’ultimo caso, affinché le dichiarazioni siano utilizzabili a fini probatori è necessario che l’imputato sia stato ritualmente informato che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l’ufficio di testimone, relativamente a tali fatti.
Il teste ex art 197 bis c.p.p (c.d. teste assistito) deve, in ogni caso, necessariamente essere assistito da un avvocato di fiducia ovvero d’ufficio a pena di nullità della dichiarazione da lui resa in giudizio (qui non si parla di inutilizzabilità ma di vera e propria radicale ed insanabile nullità).
Se poi sul testimone ex art 194 ss.ti c.p.p. grava un generale obbligo di rispondere e di rispondere secondo verità, la testimonianza assistita si caratterizza per una peculiare regolazione del diritto al silenzio in rapporto all’obbligo di dire la verità. Infatti, come prevede il comma 4 della detta norma, nel caso di connessione ex art 12 o di un reato collegato ex art 371/ 2, lettera b) il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione.
Mente, nel caso di procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371/2, lettera b) se è intervenuto l’avviso di cui all’art 64/3 lett. c) il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
Al fine di evitare ripercussioni a carico dello stesso testimone il comma 5 della norma prevede che in nessun caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’articolo in parola possano essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
Giova precisare l’ordine col quale, in dibattimento, vengono assunte le prove testimoniali:
- esame dei testimoni del PM e della parte civile;
- esame dell’imputato;
- esame dei testimoni della difesa.
Controesame
Il controesame verte sulle stesse circostanze specificate da chi ha richiesto l’esame diretto del teste al momento della presentazione della relativa lista ed è condotto dal difensore della parte avversa, con lo specifico intento di far cadere in contraddizione ovvero di confutare la deposizione del testimone medesimo.
La funzione del controesame è infatti duplice:
- da un lato vi è l’intento di contestare la ricostruzione dei fatti operata dal teste di parte avversa, con l’obiettivo di minarne la credibilità ed attendibilità (ad esempio ponendo in evidenza un suo interesse in causa, una insufficienza fisica o psichica a ricordare e ricostruire nel dettaglio i fatti oggetto di testimonianza, la contraddittorietà della deposizione ovvero la difformità della stessa rispetto alle dichiarazioni rese da altri testimoni ovvero dallo stesso dichiarante a sit nella fase delle indagini preliminari etc);
- d’altro lato vi è l’obiettivo di neutralizzare quanto il teste ha dichiarato nel corso dell’esame, giungendo a rappresentare i fatti in maniera diversa e meno favorevole rispetto alla prospettazione narrata dalla parte che ha chiesto l’assunzione della prova.
Su quali circostanze verte il controesame?
Si è detto che, tendenzialmente, il controesame dovrebbe vertere sui medesimi fatti indicati nei capitoli di prova testimoniale contenuti nella lista testi di chi ha chiesto l’esame diretto del testimone. L’asserzione si fonda sulla constatazione che dare eccessiva ampiezza al controesame potrebbe comportare l’indebito sacrificio del principio dell’ammissibilità di una prova solo se tempestivamente dedotta. Si ricorda che la lista testi va depositata presso la cancelleria del giudice che procede nel termine di almeno sette giorni liberi prima dell’apertura del dibattimento.
Tuttavia si è affermata recentemente altra corrente di pensiero secondo la quale restringere il controesame entro le strette maglie dell’esame diretto significherebbe sacrificare eccessivamente la possibilità, in capo alla parte che non ha citato il teste, di far cadere il dichiarante in contraddizione, di minarne la credibilità, di porre le c.d. domande suggestive.
Il contrasto tra i due filoni interpretativi è superato dalla prassi forense. In effetti in giurisprudenza si è affermato che la lista testi può essere redatta senza una specifica capitolazione delle domande da porre al teste, potendo bastare il generico riferimento ai fatti oggetto dei capi d’imputazione.
La compressione del diritto al controesame può configurare una nullità riconducibile nell’alveo dell’indebita limitazione del contraddittorio, e, più in generale, in quello della violazione del diritto di difesa. Si tratta di una nullità certamente non assoluta, che deve essere eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell’art. 182 c.p.p.
Di certo, in sede di controesame si possono porre le cosidette “domande suggestive” (ovvero domande che possono suggerire in parte le risposte) viceversa inammissibili in sede di esame diretto. Ciò perché mentre vi è il rischio che il teste possa essere preparato a tavolino dalla parte che ne ha chiesto l’audizione, il pericolo scema grandemente in caso di domande poste dalla parte avversa con la quale è improbabile che il teste abbia avuto contatti diretti.
Lista testi
La lista testi è l’atto scritto contenente la richiesta di una parte processuale (pubbico Ministero, parte civile o imputato) di escutere testimoni, perché vengano acquisite prove nel processo penale ad essa favorevoli. Resta inteso che la parte civile potrà depositare la lista testi solo se la costituzione avrà avuto luogo, prima del dibattimento, all’udienza preliminare, se prevista, ovvero, in caso contrario, con atto notificato all’imputato nel domicilio eletto (la costituzione di parte civile all’udienza dibattimentale impedisce il deposito di una lista testi).
La redazione e successivo deposito in cancelleria della lista testi rappresenta una tappa molto importante nel percorso di avvicinamento al dibattimento, e la sua disciplina (contenuta nell’art. 468 c.p.p.), impedendo la presentazione di prove a sorpresa, mira a preservare il lineare svolgimento del contraddittorio, nell’interesse di ciascuna parte e della buona amministrazione stessa della giustizia. Il deposito preventivo in cancelleria della lista testi permette, infatti, alla/alle controparte/controparti di accedere alla lista dei testimoni per poter organizzare la propria strategia di difesa (o di accusa, se si tratta del pubblico ministero), per esempio formulando richiesta di prova contraria. Questo principio è gemello di quello che, nei processi degli ordinamenti di common law, va sotto il nome di discovery.
La lista testi deve contenere le generalità ed il domicilio delle persone che si chiede vengano ascoltate (così da garantire la loro piena individuazione), oltre alla descrizione sommaria dei temi in merito ai quali queste dovranno rispondere.
Qualunque cittadino è astrattamente dotato della capacità di testimoniare, anche l’infermo di mente ed il minore: spetta alla discrezionalità del giudice (se congruamente motivata quanto al suo concreto esercizio) la decisione di escutere un teste con deficit psico-cognitivo o un soggetto minore di età, così come il vaglio circa l’attendibilità della loro deposizione.
A differenza di ciò che accade nel procedimento civile, nel quale attore e convenuto (o ricorrente e resistente) non possono testimoniare in quanto portatori di un interesse privato, nel processo penale è ammessa anche la testimonianza della persona offesa e del danneggiato dal reato – la cui credibilità intrinseca ed estrinseca sarà naturalmente oggetto di valutazione da parte del giudice, in maniera ancora più rigorosa di quanto avvenga per gli altri testimoni. Va precisato che, sotto il profilo terminologico, la sottoposizione dell’imputato, che dichiari di voler rispondere, alle domande delle parti processuali (in quanto costui ha un inviolabile diritto al silenzio) è definita esame.
Quanto ai tempi per la presentazione delle liste testi, il comma 1 dell’art. 468 c.p.p. stabilisce perentoriamente che la lista vada depositata nella cancelleria del giudice davanti al quale pende il processo, non oltre 7 giorni liberi prima della data fissata per la prima udienza dibattimentale (vale a dire entro l’ottavo giorno solare precedente la prima udienza dibattimentale). I testimoni indicati oltre quella data non potranno essere ascoltati in quanto la relativa deduzione istruttoria sarà dichiarata inammissibile dal giudice per tardività.
Un’apertura riguardo alla perentorietà del termine di deposito della lista testi arriva, tuttavia, dalla Corte di Cassazione (vd. sent. 41662/2016 Cass. pen. sez. V) a proposito dell’esame dei testi a controprova. In questo caso, gli Ermellini hanno ritenuto ammissibile l’escussione dei testimoni dedotti a controprova anche da parte del difensore che non abbia presentato tempestivamente la lista testi per la prova diretta.
I testimoni indicati in lista testi potranno essere sostituiti con altri solo a seguito di autorizzazione del giudice ed unicamente con riferimento ai temi di prova indicati in lista testi quale oggetto della deposizione del teste sostituito.
Cosa fare se ci si dimentica di depositare la lista testi?
Se la mancata presentazione della lista testi non dipende da inerzia dell’assistito ma da dimenticanza ovvero negligenza del difensore, a carico di questi sono profilabili in astratto ipotesi di responsabilità professionale ed egli è dunque chiamato a fare tutto il possibile per rimediare. Come?
- Chiedere di essere ammesso a prova contraria, una volta letta la lista testi del pubblico ministero;
- Attendere che sia terminata l’escussione dei testi ammessi e, prima che il giudice abbia dichiarato chiusa la fase istruttoria e dato la parola alle parti per le conclusioni, sulla base del disposto dell’art. 507 c.p.p, chiedere l’ammissione di testimoni che si rivelino decisivi ai fini del decidere, ovviamente argomentando con chiarezza ed in modo convincente circa la necessità assoluta dell’integrazione istruttoria con l’audizione del testimone da ultimo indicato.